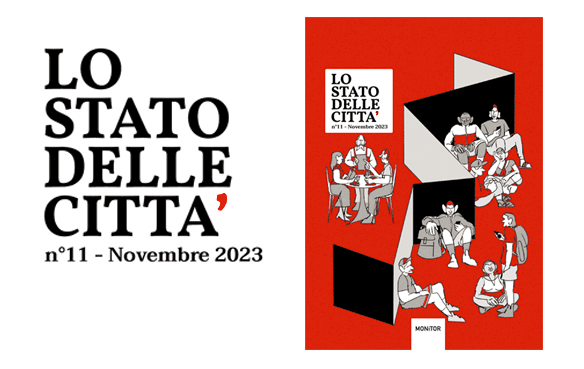Riproponiamo a due anni di distanza queste cartoline dall’estate pugliese, dal numero 11 (novembre 2023) de Lo stato delle città. Nel frattempo la svendita del territorio procede di emergenza in emergenza: la xylella degli ulivi, lo spopolamento, l’assalto a terre e coste per impianti eolici e fotovoltaici, il consumo di suolo per resort di lusso, la crisi idrica, la devastazione degli incendi. Mentre gli amministratori locali sembrano agiti da forze estranee e i sedicenti intellettuali fomentano lo storytelling dominante, due vicende esemplari su tutte.
Lo scorso maggio i comuni attraversati dal gasdotto Tap hanno ratificato un accordo con la multinazionale che prevede il ritiro della costituzione di parte civile nel processo contro Tap, la rinuncia alle compensazioni per la costruzione dell’opera (e per il suo previsto raddoppio) e la rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti dell’azienda e dei suoi dirigenti, in cambio di otto milioni da parte di Tap, spiccioli per comprare il consenso del territorio, delegittimando le ragioni di chi ha lottato contro il gasdotto. La svendita continua con la sponsorizzazione da parte di Tap di festival culturali e rassegne di eventi estivi.
In un paese del basso Salento, la sindaca ha emesso un’ordinanza con cui vieta iniziative politiche, manifestazioni e volantinaggi nel centro storico per la stagione estiva. Ha giustificato il divieto sottolineando l’importanza di non creare disagi ai turisti “interessati alle attività di puro svago” e di preservare la reputazione del paese, che farebbe parte dei “borghi più belli d’Italia”.
La pietra è sempre più rovente, le poche sparute gocce evaporano senza tempo di scorrere.
* * *
la prima volta che ho sentito dire in salento ero ragazzina e ascoltavo una canzone di biagio antonacci che passava in ogni radio quell’estate. si era sempre usato nel salento, e nemmeno così spesso come adesso, una decina di anni dopo, che sembra un marchio registrato quando chiedo al bar del mio paese un caffè in ghiaccio col latte di mandorla e mi sento rispondere “ah, un caffè salentino!” e ritrovo lo stesso marchio in un autogrill lontano dalla puglia. anche se la musica cavalcava la moda della “vacanza in salento” a noi non importava di avere turisti tra i piedi, perché sceglievamo gli scogli più inaccessibili per passare le giornate al mare senza adulti nei paraggi. sempre in quegli anni, in viaggio a parigi trovo un enorme padiglione nella piazza della tour montparnasse con una mappa della mia regione e la scritta #weareinpuglia, e ingenuamente col mio primo smartphone scatto una foto. estate dopo estate spuntano sempre più lidi privati, alberghi, lounge bar e cocktail bar sul mare, bistrot, bancarelle di souvenir, eventi musicali invischiati in una falsa coscienza che li spaccia per rituali arcaici. negli anni quell’hashtag ha scolpito un salento ridotto a “terra del rimorso” fuori dalla storia, un non-luogo dove non c’è altro che tamburelli, balli e taralli.
IL MONDO DEI (CON)VINTI
riemergo come sputata dalla risacca delle pagine di recita estiva di christa wolf, libro che da qualche giorno ho finito ma continuo a riaprire, quasi che impastarmi a parole e immagini possa farmi capacitare che quello che ho letto è ancora lì. un gruppo di amici abbandona la città per cercare nella campagna isolata un rifugio alla delusione per un mondo in cui non si riconosce. alle prime pagine sono pronta a difendermi dalla nausea per la retorica della vita campestre come idillio della pienezza esistenziale, del margine come ultimo presidio di resistenza. invece lo scudo non serve, il loro non è un ritirarsi, un ripiegamento, è più una dislocazione per non lasciar opacizzare l’utopia ma senza clemenza per se stessi e gli altri. “adesso! così ci urlavano le cose pretendendo la liberazione. con la stessa intensità con cui esse erano costrette a essere se stesse, dovevamo essere noi stessi”, e mi sembra che la storia venga a stanarmi nell’interstizio dove cercavo di nascondermi. è una domenica di fine luglio, le stesse strade che fino a pochi mesi fa erano vuote ora sono un ingorgo di auto con targhe straniere, mentre palchi per spettacoli e tavolini dei ristoranti corrodono lo spazio pubblico. la campagna che domina appena fuori i piccoli nuclei abitati potrebbe essere la stessa del libro, ma qui è costretta a fare da sfondo a b&b, masserie tradite e convertite in resort di lusso, ville da affittare e sentieri da percorrere a piedi seguendo gli itinerari di qualche guida turistica che investe i passi di un significato artefatto (come se per camminare sullo sterrato servisse un animo sensibile e nobile).
nelle pagine di recita estiva ricorre la foga dei figli dei contadini di sbarazzarsi di quello che resta nelle case che ereditano. utensili, vasellame, mobili che hanno accompagnato i lavori e le vite dei padri sono tracce di un mondo con cui i figli non vogliono mai più avere a che fare. mi torna in mente una scena minima che ho spiato qualche sera prima tra le stanze del museo della civiltà contadina di calimera. ascolto una signora che guida la compagna turista attraverso l’esposizione leggendo i nomi sulle targhette e traducendo il dialetto (con la pronuncia esotica volutamente marcata di chi quello stesso dialetto lo scansa come gergo volgare). davanti a un telaio antico per tessere a mano aggiunge «a casa di mia madre ne avevamo uno così, poi non so che fine ha fatto», ma un po’ se ne vergogna e aspetta in bilico di scorgere nello sguardo dell’interlocutrice tracce di disprezzo per le origini umili o di ammirazione per le radici autentiche. come se la rimozione e la negazione di essere appartenuti a una cultura subalterna siano stati una tappa ineludibile per accedere al benessere (decenni più tardi che altrove). barattare tutto quello che avevano per emanciparsi alle novità e riguadagnare in fretta i gradini verso la vera civiltà. come una scena di lazzaro felice in cui il ragazzo riconosce delle erbe spontanee commestibili (che oggi troneggiano nei menu gourmet) ai margini delle rotaie di una periferia metropolitana, ma gli ex contadini memori delle condizioni di sfruttamento a cui erano costretti per lavorare la terra non vogliono saperne di raccoglierle, a costo di sfamarsi con patatine scadute rubate in una stazione di servizio.
oltre ad aver dimenticato, qui gli “autoctoni” hanno presto introiettato la condizione di abitanti di un’enclave turistica elitaria e si sono prodigati (alcuni inconsapevolmente) ad aggiungere tinte pittoresche alle narrazioni fasulle di turismo e folklore, mentre le foto di scontrini sui social per lamentarsi dei prezzi assurdi di un caffè o di un rustico restano campo di commenti atrofici. intorno alle reti che hanno creduto di lacerare con l’emancipazione e il progresso se ne sono annodate di nuove: dallo sfruttamento dei latifondisti e delle manifatture di tabacco a quello mercificante della monocultura turistica.
TURISMO O TERRORISMO
cerco di non ascoltare le voci che dalla televisione ammoniscono di bere acqua e stare all’ombra, ma in uno di quei programmi saturi di già-detto che riempiono le fasce orarie in cui la gente in vacanza non vuole essere ammorbata coi tg mi capita un’intervista amichevole a massimo bray (il suo nome non mi suona vuoto perché bray è leccese e ha una casa vacanze nel mio paese; a fine intervista non manca di confessare il suo amore nostalgico per “la vecchia bottega alimentare di un paesino in provincia di lecce, marittima”). dopo gli orpelli di ministro presidente direttore, bray intraprende una crociata in difesa dei borghi e della gestione che l’italia ne fa. “l’italia è il paese che ha inventato i festival, abbiamo creato comunità grazie alla cultura”. poi stizzito reclama che “questa forma di pessimismo che ci assale deve finire, noi dobbiamo essere orgogliosi che si venga in italia”, perché “di fronte a una vita frenetica noi siamo capaci di far stare centinaia di persone in un piccolo borgo, farlo rivivere e creare quel senso di comunità”.
li chiamano borghi per omologare sotto un’unica etichetta centinaia di paesi, negando a ognuno il suo carattere, la storia, la voce, il dialetto, i canti, le tradizioni che gli appartengono, schiacciando sotto una parola sola tutto quello che suona bene chiamare identità. la chiamano comunità come se la prossimità fisica di troppe persone nello stesso posto implicasse la vicinanza d’animo. poi chi l’ha detto che il borgo voglia una seconda vita da terra colonizzata? meglio morire di incuria e abbandono che schiavo della religione del marketing. non che ci sia tanto da vantarsi per il dilagare di festival, happening, performance, che incarnano il paradigma della transitorietà, dello straordinario contro l’ordinario, grandi eventi che attraggono turisti e fanno da alibi a privatizzazioni spietate invece che manutenzione sul territorio e assunzioni permanenti delle persone che quei luoghi li vivono (e che i festival sfiorano appena). forse il senso di comunità che sbandierano non è riuscito a sopravvivere all’emigrazione e allo spopolamento perché a questi paesi è stata negata l’ovvietà di immaginare un futuro. senza un orizzonte, condivisione, solidarietà, convivialità restano slogan per guide turistiche e costumi rigidi entro cui i paesani vengono relegati finendo per recitare se stessi.
penso al ciclo di isteresi, un grafico di una curva chiusa su un libro di fisica all’università: certi materiali sottoposti all’azione di un campo magnetico non tornano più allo stato vergine quando l’azione cessa, restano magnetizzati anche in assenza di corrente, e ogni sostanza ha una temperatura critica oltre cui perde le proprietà che la caratterizzano. guardo le spiagge e le strade che si gonfiano fino a esplodere di corpi e auto, poi tornano sventrate e deserte per un po’ di mesi in un ciclo che si ripete. non riesco a convincermi che viviamo solo in funzione della stagione (come se l’estate fosse l’unica che conta in tutto l’anno, il resto è letargo), che siamo un posto per villeggiatura, che le case se ne stanno vuote aspettando di essere invase senza risentire dell’oltraggio che subiscono. non riesco a convincermi che non sappiamo più cosa vuol dire abitare, creare abiti, abitudini, forme di vita comune. davvero abitare è sinonimo di consumare? che cosa sono i paesi se li pensiamo a partire dall’abitare? penso ad antonio neiwiller che proprio in un paese della provincia di lecce nell’estate del 1991 diceva “io appartengo a questa terra, a questa parte della terra che ora non riconosco più. io voglio difendere differenze, particolarità, gesti, atti, io voglio ancora difendere questa parte del mondo. chi l’ha detto che tutto questo debba essere violentato così”.
SE MI SVENDO NON COLLASSO
a giugno una scuola di melendugno, insieme al comune e all’azienda tap (ancora sotto processo per inquinamento ambientale e contaminazione della falda acquifera), comunica di voler dedicare ai ragazzi alberi che saranno piantati nei terreni dell’impianto della multinazionale per raggiungere obiettivi di sostenibilità. dopo l’arte pubblica asservita a riqualificazioni che pretendono di risanare gli spazi urbani mentre li convertono in luoghi a uso e consumo del turismo, il capitalismo si appropria di pratiche virtuose svuotandole di senso e piegandole a scopi altri. e noi a testa bassa raccogliamo le noccioline che l’invasore ci lancia tra le sbarre dello zoo.
se c’è una costante, è il salento che si vergogna di se stesso. la musica abiura le sue radici povere, travisa la funzione del canto e camuffa le condizioni bestiali di lavoro dei braccianti con un contesto bucolico in cui la miseria è ridotta a feticcio che incipria di esotico il panorama. ciò che doveva curare e salvare (il canto e la musica come terapia per il tarantismo) accelera la distruzione di un territorio e della sua storia violentata dal marketing. le contraddizioni annichilite (non è poi lo stesso meridione che tacciano di corruzione, mafia e arretratezza?), le complessità appiattite a “un’immagine dimezzata”, diceva gianni bosio: “il buon selvaggio, l’uomo che è buono in quanto dimensione astorica, l’uomo folklorico. è questa la sola misura lecita per l’uomo storico contemporaneo e subalterno per partecipare al festino della cultura politica della classe dominante. l’uomo storico, l’uomo politico, l’uomo della fabbrica e dei campi, viene semplicemente ignorato”.
l’istituto carpitella, fondato nel ’97 per difendere e diffondere la cultura orale del salento, tradisce radicalmente i propri scopi un anno dopo con il festival della notte della taranta che ha monopolizzato tutte le energie e i soldi nella sua organizzazione, e ogni sforzo per ricerca, studio e archiviazione della memoria tradizionale è stato stroncato (già dal palco di melpignano nella prima notte della taranta uccio aloisi ammoniva, prima ancora di battere sui tamburi, “nu s’ave perdere tiempu”, non si deve perdere tempo). schiere di assessori e di esperti usano la “pizzica” come strumento per costruirsi carriere in politica, tanti mitridate che hanno ceduto passano dalla critica totale alla collaborazione con la notte della taranta contendendosi palchi e cachet, dando l’impressione che l’interesse personale e il ritorno di immagine contino sempre più di ogni altra cosa. sembrano i protagonisti di una ballata di brecht, “oggi mi hanno fatto vedere il loro mondo, ho visto solo il dito, tutto insanguinato, allora in fretta ho detto che era di mio gusto”. roberto raheli degli aramirè, editore illuminato e unico difensore incorrotto di quella cultura, che abbandonato da tutti ha abbandonato tutto nel 2007, denunciava la “deliberata manipolazione della realtà storica a uso pubblico, attraverso la creazione di una serie di icone, come quella del ragno e del tamburello, o quella del salento edonistico-dionisiaco dove tradizionalmente i contadini al termine del lavoro si riunivano nell’aia della masseria a ballare sfrenatamente la pizzica”.
pasolini sperava che gli uomini avrebbero risperimentato “il loro passato, dopo averlo artificialmente superato e dimenticato in una specie di febbre, di frenetica incoscienza”. ma ora che la sintesi linguistica della modernità ha abolito il passato prossimo e l’imperfetto, non ci resta che dissotterrare un passato remoto. un passato che, oltre ad aver dimenticato, abbiamo tradito: i canti che si ascoltano dai concerti restano solo “quello sforzo ingrato di dirsi vivi in una lingua morta”, per dirla con gabriele frasca; il dialetto mortificato nei ritornelli in bocca ai “grandi” nomi dello spettacolo chiamati a partecipare al festival e a distogliere ogni tentativo di scorgere il marcio delle cose, le ragazzine che credono di conoscere il ballo tradizionale del loro territorio e invece copiano le movenze seducenti del corpo di ballo sul palco disegnate da qualche coreografo, ignare che la pizzica si ballava forse due volte l’anno con una serie di restrizioni, con garbo e pudore. abbiamo tradito tutto il possibile, non c’è più niente e nessuno da tradire. che fare allora, se “tutto è in armonia nel modo sbagliato e ogni cosa va in frantumi nel modo giusto” (ancora recita estiva)? che fare dei paesi una volta che la cultura che li ha animati si è estinta con i suoi abitanti? che fare della cultura popolare, delle tradizioni, dei riti, una volta che è venuto meno il mondo che li ha generati?
ATROCE PAESE CHE AMO
partecipo alla presentazione di un libro di poesie in un giardino appartato dagli odori dei ristoranti e dalla musica dei locali. mi ritrovo a voler scappare tra una platea che sembra aver eletto se stessa a casta superiore. si riconoscono al primo sguardo i turisti in abiti da vacanza (e i non-turisti ne imitano lo stile): camicie di lino, cappelli panama, lunghi vestiti e caftani che cercano di apparire frugali ma so troppo bene quanti empori vendono quei tessuti spacciandoli per opere di tessitrici locali che conservano l’arte del telaio (mentre gli unici telai superstiti sfornano tessuti per dior e lecce conferisce cittadinanze onorarie a fashion designer che scelgono il salento come vetrina) per abboccare all’umiltà apparente. sono gli stessi turisti che strisciano con innaturale lentezza dentro auto troppo grosse per attraversare indenni le stradine dei paesi non progettate per il grande traffico estivo. assistono alle letture di versi come a una liturgia consolatoria che celebra il loro status di cittadini edotti all’arte, civili, che il massimo picco di adattamento all’habitat lo raggiungono mangiando la frisa con le mani e non con le posate. li riconosci mentre vagano alla ricerca di tipicità: la pasta fatta in casa diventa esclusiva dei ristoranti, il grano arso una ricercatezza culinaria e solo cinquant’anni fa l’emblema della miseria, ottenuto dalle ultime spighe bruciate sfuggite alla mietitura manuale. però loro si autoassolvono eleggendo franco arminio a profeta della nostra epoca quando canta il “bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di gente che ama gli alberi e riconosce il vento”. eppure gli risponde decenni prima errico malatesta: “se tu leggi i poeti li trovi tutti pieni di entusiasmo per la vita campestre. ma la verità è che i poeti che stampano libri, la terra non l’hanno zappata mai, e quelli che la zappano davvero si ammazzano di fatica, muoiono di fame, vivono peggio delle bestie, e sono calcolati come gente da nulla”.
quando non c’è più un punto dove posso volgere lo sguardo senza che si facciano incontro con il loro carico pensieri caustici mi arrendo a fare un giro in campagna, anche se questo si traduce in attraversare ettari di rami secchi e tronchi sgozzati quando va bene, odore di bruciato e residui di roghi quando va male. stavolta il suono delle campane di capre e pecore mi anticipa i passi, il pastore che conosco bene quando mi vede spegne la radiolina con l’antenna che si porta nella tracolla per farsi compagnia nella desolazione dei campi. senza preamboli di circostanza mi racconta delle sanzioni di un controllo asl per piccole falle nel laboratorio in cui lavora il latte. lo aveva piastrellato e messo a norma quando uno dei figli ha deciso di continuare il suo mestiere nonostante lui lo scoraggiasse di continuo, anche con rabbia, perché “non deve fare ‘sta vita, con il mondo di oggi esci pazzo”. eppure il controllo ispettivo si incaglia per l’assenza di un certo formato specifico di trappole per topi, così ai soldi spesi per sistemare il laboratorio si aggiungono i soldi per la sanzione e le altre modifiche imposte. ormai il prezzo dei prodotti detta gli standard di lavorazione, una piccola azienda zootecnica ha le stesse spese di un’impresa di allevamento a prescindere dalla dimensione, per il mercato cinque capre o cinquecento è la stessa cosa. penso ai villani di donpasta, a santino galasso di taranto che sorride mentre dice “t’ha mettre ‘a cape ssott’ e ha sce ‘nnanz”, devi abbassare la testa e andare avanti, a totò fundarò di alcamo che fa la conserva di pomodoro a casa e si incazza perché secondo la legge quella conserva non può esistere, è illegale, ma è impossibile produrre cibi genuini rispettando le regole. penso che anche la cultura genuina può essere solo clandestina. penso a civitonia, un festival per civita di bagnoregio che in clandestinità esiste senza essere accaduto. “sappiamo bene quanto il mantra dell’accumulazione capitalistica, insidioso e colonizzante, spazzi via ogni parola dissenziente”, si legge sul libro che dà un supporto fisico all’immaginare di civitonia. “sappiamo bene di avere una lingua logora e stanca” (una volta in una traduzione di guido ceronetti avevo letto “si stanca qualsiasi parola, di più non puoi fargli dire”). eppure, “la consapevolezza della devastazione in atto dovrebbe obbligarci a ricaricare parole ormai atrofizzate con l’obiettivo di far tracimare lo stagno paludoso che ci immobilizza”.
“riscrivere la fine o dell’arte del capovolgimento”, leggo sotto il titolo del libro, e infatti civitonia è anche un affronto al pensiero di chi governa quel territorio, è un festival che rinunciando al suo accadere si è salvato dall’essere fagocitato dall’industria turistica o dalle politiche urbane che piegano l’arte a progetti di presunta riqualificazione buoni solo per ingrassare coi fondi pubblici.
“ad accendersi ancora è il segnale che dovrei fare qualcosa. ogni giorno. insomma io sono come un quadro segnaletico dove si accendono continuamente lampadine di diversi colori. sicuramente produce un bel fregio luccicante. solo che non serve a niente”, sottolineo tra le pagine di recita estiva. in matematica essere impossibilitati a eseguire operazioni è la molla per immaginare, per costruire domini numerici più ampi: dai numeri naturali agli interi negativi, dai numeri reali agli immaginari, domini che contengono ciascuno il precedente e dai loro spalti si ha una vista sempre più ampia e sfaccettata. se x2+1 resiste alla possibilità per i polinomi di essere scomposti in monomi lineari, si può scomporre abbandonando il campo dei reali e sollevandosi nel dominio degli immaginari.
cosa serve allora? ammettere che i nostri mezzi sono difettati e monchi, e quindi cercare scarti, biforcazioni possibili, non soluzioni miracolose ma indizi minuti per scardinare l’inerzia e scommettere su un futuro differente. ammettere che il buio ci soffoca e cercare barlumi, intermittenze, una ricomparsa delle lucciole, forse destinate a morire travolte dalla luce sporca delle stelle di un hotel. presidiare le trasformazioni urbane, rivendicare processi condivisi, farsi carico del mostruoso ma cercare angoli da cui guardarlo senza esserne assuefatti. cercare di arrivare a un risultato per vie traverse mi riporta alla matematica, al metodo dimostrativo per assurdo: si ottiene il vero facendo scaturire l’impossibile a partire dal falso, ci si situa in ciò che si ritiene essere falso e si mostra come questo conduca a una conclusione impossibile.
per assurdo si dimostra un teorema fondamentale di cantor che dice che dato un insieme ci sono sempre più parti di quanti siano i suoi elementi (si dimostra che non ci possono essere tante parti quanti elementi e si sa che non possono essercene meno). il teorema di cantor confuta il dilagare dell’individualismo: il fatto che in un insieme qualunque ci siano più parti che elementi significa che la profonda risorsa di ciò che è collettivo prevale su quella dei singoli, come il coro prevaleva nelle esecuzioni musicali spontanee. fa eco il barone rampante: “le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto, di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone”. allora organizzarsi, agitarsi, frantumare la cappa del disincanto, distogliere lo sguardo dai fari del treno in corsa che sta per travolgerci. brecht incalza: “vi accontenterete del cielo che splende? sarete sfamati? sarete consolati? il mondo guarda a voi con la sua ultima speranza. più a lungo voi non potete essere contenti di una goccia simile sulla pietra rovente”.
mi illudo che scrivere possa far sopravvivere qualcosa, strappare qualche brandello al vuoto che si scava, tracciare da qualche parte un solco. ma suona amaro il monito di rina durante, “tu capisci che in questa provincia senza fine rimani solo tu ultimo cavaliere senza né briglia né staffe a portare il peso di una storia che finisce”. mi illudo che cucire insieme parole che mi stagnano dentro possa avvicinarmi a una realtà che non so comprendere né contenere (e quando riesco mi lacera, perché la stessa vanga può scavare solchi dove seminare o sotterrare cadaveri). ma di fatto sto scrivendo per prendere le distanze, per espellere la materia scottante ingabbiandola in queste cartoline. allora se pure il racconto brucia la sua materia per alimentarsi, almeno che produca fiamma anziché riscaldare le ceneri. (chiara romano)