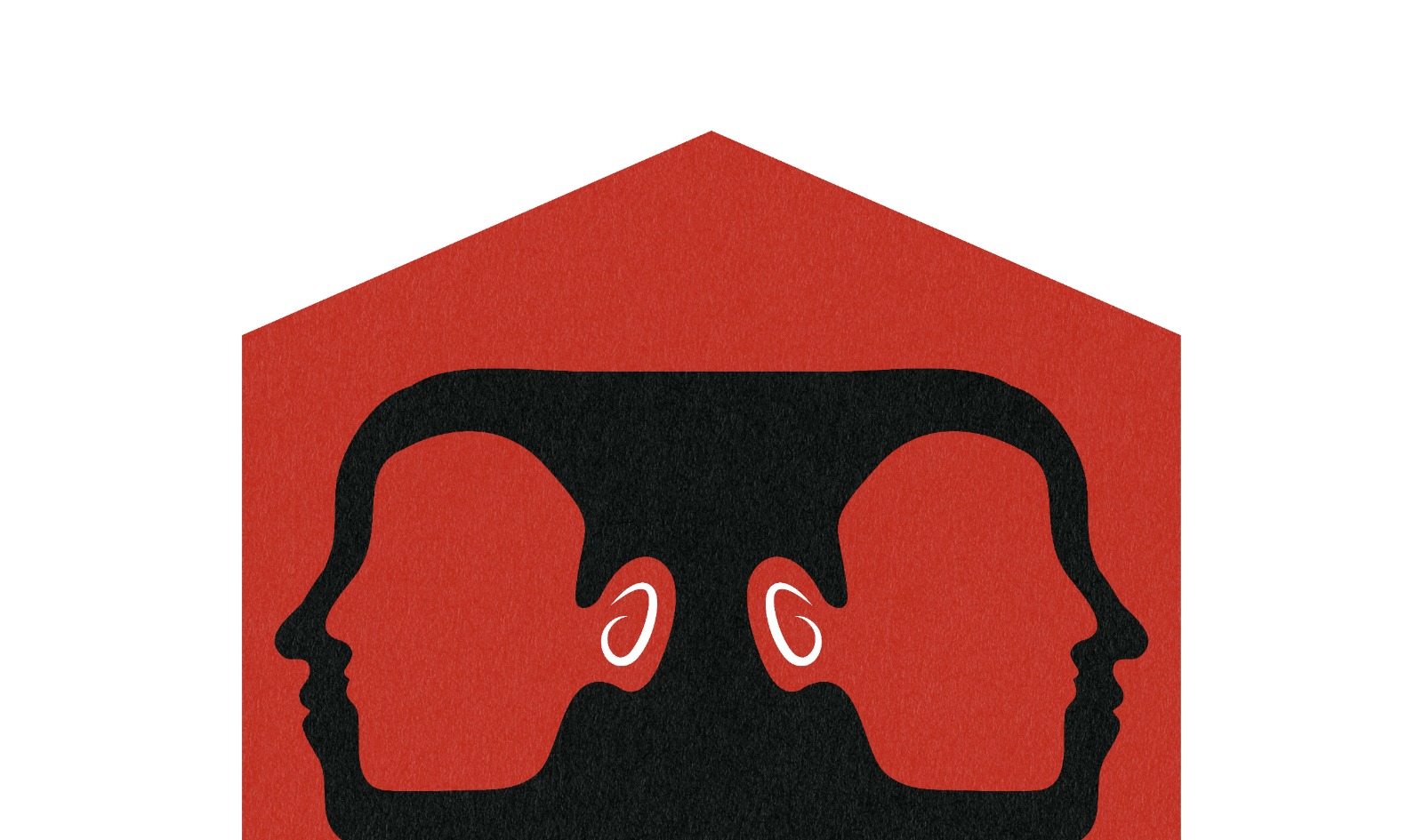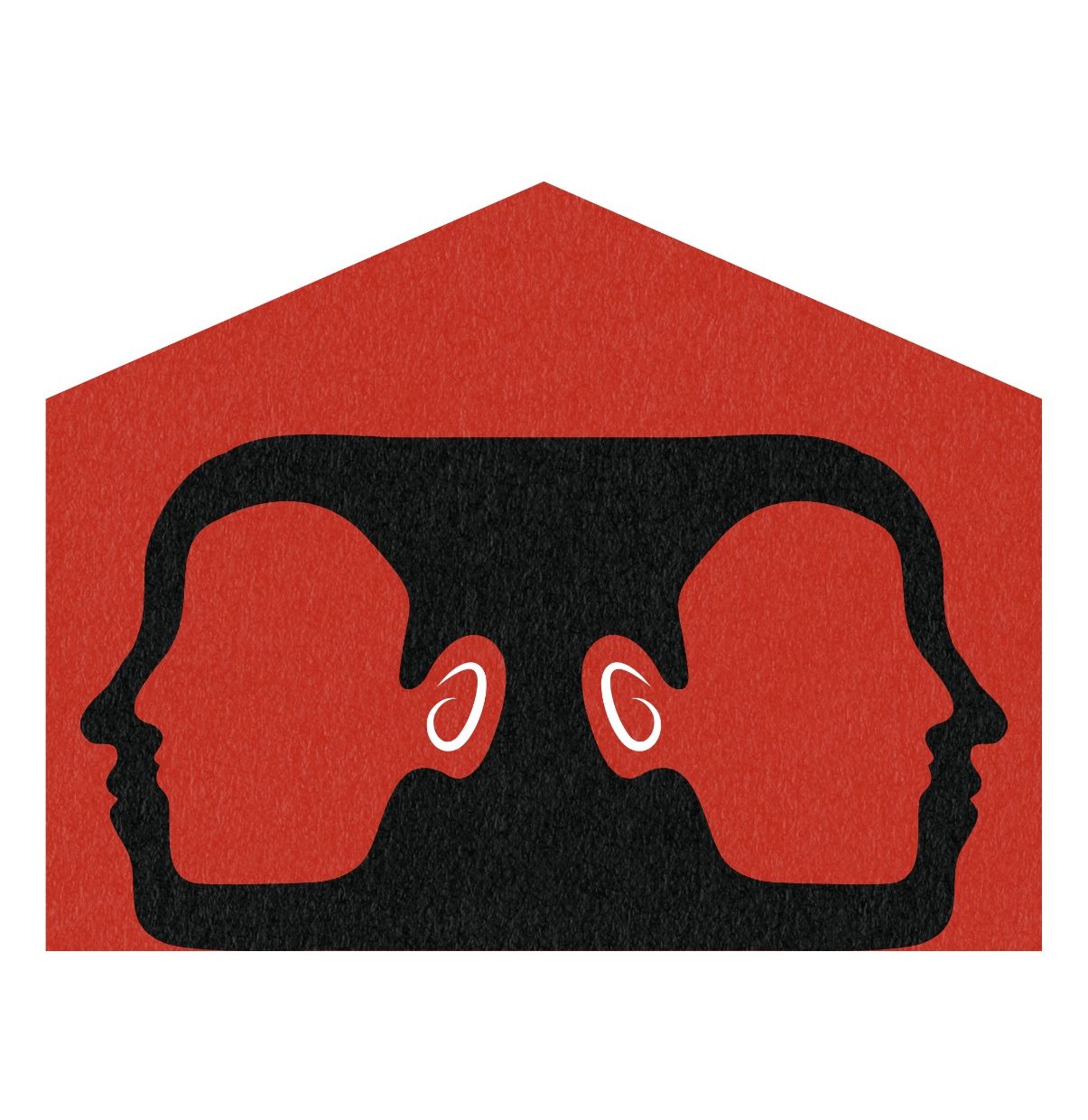
Che cosa significa, oggi, richiedere il diritto alla vita in Tunisia? A Gabès, città del sudest trasformata in una zona di sacrificio, la risposta risuona nelle piazze.
Riecheggia, in questi giorni, la sensazione che vivere a Gabès, la più grande città del sudest tunisino, sia come vivere in una zona di guerra. Un tempo nota per ospitare un sistema unico al mondo di oasi litorali, la città è ora paradigma di un sistema di sfruttamento del territorio senza limiti né confini. Le ragioni sono da ricercare nelle relazioni coloniali tra Sud e Nord globale e, nello specifico, nella trasformazione del territorio tunisino in una fabbrica a cielo aperto per la produzione – per lo più – di fertilizzanti da esportare in Europa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i casi di soffocamento. È però nei paradossi del capitale che si sviluppano comunità resistenti in grado di inceppare l’avanzare delle faglie dell’accumulazione. È quanto sta accadendo questo mese nel territorio di Gabès, dove, a partire dall’inizio di ottobre, si sono susseguite una serie di mobilitazioni finalizzate allo smantellamento delle unità produttive inquinanti del Groupe Chimique Tunisien (GCT). Le proteste, che hanno raggiunto il loro apice nel grande sciopero regionale del 21 ottobre, affondano le radici nei numerosi casi di soffocamento verificatisi a settembre. Le aree circostanti il complesso chimico e industriale sono state – e continuano a essere – colpite da fughe di gas tossici che causano asfissia, difficoltà respiratorie e motorie nelle persone esposte. Tra queste, numerosi bambini e bambine che il 10 ottobre sono stati trasferiti in ospedale perché, mentre erano in classe, stavano improvvisamente soffocando. Le immagini virali di quel giorno hanno segnato un punto di rottura definitivo per un territorio che da decenni si mobilita per rivendicare il diritto alla vita. La risposta della comunità è stata immediata e, nei giorni a seguire, si sono susseguite numerose proteste davanti ai cancelli della GCT, durante le quali non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine.
In questo clima, il 14 ottobre si sono verificati nuovi casi di soffocamento, scatenando una nuova ondata di rabbia raccolta nella marcia popolare del giorno seguente. I video di quei momenti mostrano scene di forte tensione e una rabbia sociale diretta contro gli impianti inquinanti dell’industria dei fosfati. Le oasi e le spiagge, un tempo descritte come un paradiso terrestre e oggi devastate dalla contaminazione, sono diventate teatro di scontri tra polizia e manifestanti, con l’uso di gas lacrimogeni. È di quei giorni anche la notizia, diffusa dall’ospedale, della fine delle bombole d’ossigeno necessarie per trattare i casi di asfissia.
Segue il tentativo di organizzare la rabbia: a guidare il processo c’è il movimento ecologista Stop Pollution, nato a Gabès dopo la rivoluzione e oggi capofila nella resistenza al disastro ecologico. Cosa succede quando un corpo “rifiutabile” diventa corpo politico? Quando la lotta per sopravvivere si trasforma in sabotaggio delle relazioni di scarto? Sale la marea. Dalla convergenza tra Stop Pollution e lo storico sindacato UGTT nasce la chiamata allo sciopero regionale del 21 ottobre, che ha coinvolto oltre centomila persone e ottenuto l’adesione totale delle attività commerciali del territorio. Le immagini di quella storica giornata raccontano una comunità che, all’unisono, rivendica il diritto alla vita e lo smantellamento delle unità produttive responsabili di un genocidio urbano senza precedenti nel territorio tunisino. Il popolo si solleva contro la narrazione tossica dello sviluppo, secondo cui alcune comunità sarebbero residuali e sacrificabili, inondando le strade di Gabès con una mobilitazione senza eguali.
LE RADICI DEL DISASTRO
Le cause del dissenso nel sudest tunisino sono antiche e risalgono alla scoperta, durante la colonizzazione francese, di fosfati nell’area. A partire da allora, l’intera economia materiale e immateriale della regione è stata stravolta e asservita all’estrazione e successiva lavorazione dei fosfati, portando sul lungo termine a una catastrofe ecologica e sociale. L’instaurarsi del monopolio minerario, di cui ancora oggi la Tunisia è schiava, ha consolidato il modello estrattivista basato sulla marginalizzazione sociale e sulla degradazione ambientale. Così Gabès, per la sua posizione strategica, è stata scelta come nodo principale di trasformazione dei fosfati, culminando nella costruzione nel 1972 dell’impianto del GCT. Raccontare cosa avviene a Gabès impone una difficoltà: non si sa dove cominciare. L’impatto ecologico del GCT si inserisce in un quadro più ampio di sfruttamento eccessivo delle terre e delle risorse idriche delle oasi che ne hanno determinato la progressiva scomparsa. Oggi si parla della morte del corpo dell’oasi, metafora potente per la lenta agonia di Gabès. La quasi totalità delle oasi è stata sacrificata per lasciare spazio all’urbanizzazione seguita all’insediamento industriale, ma l’aspetto più grave riguarda l’espropriazione delle risorse idriche: per esempio, nell’oasi di Chenini erano presenti quattrocento sorgenti naturali utilizzate collettivamente e gratuitamente per l’irrigazione; oggi sono tutte esaurite.
Quando si parla di acqua, bisogna inoltre guardare al mare, dove quotidianamente l’impianto del GCT scarica — senza alcun trattamento — gli scarti della produzione. Nello specifico, si tratta del fosfogesso, pericoloso a causa dell’elevata presenza di metalli pesanti e materiali radioattivi. Nel corso dei decenni, ciò ha causato un crollo drastico della biodiversità del golfo, che è passato da ospitare duecentocinquanta specie nel 1965 a sole cinquanta nel 2023. Parallelamente all’espropriazione e contaminazione dell’acqua, le ciminiere rilasciano costantemente ammoniaca, anidride solforica e ossido di azoto, trasformando l’aria in veleno. A marzo è emersa anche la notizia della pianificazione di nuovi impianti per la produzione di ammoniaca e idrogeno verde. Dinnanzi a tutto ciò, possiamo davvero parlare di emergenza? Da decenni Gabès soffoca non per un incidente, ma per causa diretta di politiche neocoloniali che si perpetuano. In tal senso, le rivendicazioni dei movimenti sociali ed ecologisti sono chiare: lo smantellamento delle unità inquinanti e la riconversione ecologica del territorio, insieme a un’indagine sugli impatti dell’industria. Le mobilitazioni proseguono, e il 25 ottobre una grande marcia di sostegno ha raggiunto la capitale, inondando le strade di Tunisi.
LA DOPPIA FACCIA DEL POTERE
Davanti a questo grande movimento popolare, il presidente Kais Saied ha dovuto prendere posizione, garantendo sostegno e solidarietà. Con una strategia tipica, però, ha scaricato la responsabilità del disastro sui governi precedenti, senza offrire prospettive concrete d’intervento. L’unico intervento tempestivo osservato è stato quello delle forze dell’ordine, impegnate a difendere le macchine della morte e a reprimere con violenza i manifestanti. La crisi di Gabès rappresenta un banco di prova cruciale per Saied, che dal 2021 ha intensificato la repressione contro ogni forma di dissenso. Recentemente, sono state sospese per un mese organizzazioni storiche come l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, il Forum Tunisien pour les Droit Economiques et Sociaux e la rivista indipendente Nawaat. Queste sospensioni si inseriscono in una strategia di silenziamento della società civile tunisina, tesa a controllare e limitare ogni opposizione al potere assoluto del presidente. Gli arresti politici – fondati su decreti contro la “cospirazione contro la sicurezza di Stato”, come quello del giudice Ahmed Sawab, condannato a cinque anni di carcere dopo un processo lampo – testimoniano il vortice di regressione democratica in corso. Dal luglio 2021, con lo scioglimento arbitrario del parlamento e l’accentramento dei poteri nelle mani di Saied, le istituzioni si sono progressivamente indebolite, la magistratura subordinata all’esecutivo e le libertà civili fortemente ridotte.
La crisi di Gabès mette in luce non solo le sfide ambientali e sociali, ma anche la profonda crisi politica e di legittimità del regime, che risponde con repressione e controllo mediatico piuttosto che con soluzioni inclusive e trasparenti. A soli tredici anni dalla rivoluzione, il popolo tunisino torna a chiedersi cosa significhi davvero lottare per la propria vita in un contesto dominato da violenza e repressione. Nel 2024 e 2025, parallelamente a proteste sociali e ambientali, sono stati registrati ulteriori arresti arbitrari di attivisti e manifestanti. Un caso emblematico è quello di Mohamed Ali Rtimi, attivista queer dell’Association tunisienne pour la justice et l’égalité, arrestato durante una mobilitazione di Stop Pollution il 23 maggio 2025. Le recenti proteste a Gabès sono state represse con arresti e detenzioni arbitrarie, spesso in condizioni che violano i diritti processuali, con accusati privi di avvocati e accusati ingiustamente di essere “cospiratori finanziati dall’estero”. Gli arresti di massa – oltre centocinquanta in due settimane – e la repressione delle proteste pacifiche dimostrano una chiara volontà politica di criminalizzare la mobilitazione popolare e soffocare ogni voce critica. Gabès torna però a sollevarsi, si fa marea contro un potere che vorrebbe sacrificarla, inondando ancora una volta le strade il 31 ottobre. Lottare per il diritto alla vita a Gabès significa rivendicare un diritto basilare come quello di respirare ma anche quello di restare, o meglio, tornare: tornare ad abitare un territorio senza che ciò costi la vita. Significa essere quel sole che sorge ogni giorno, tra i colori lividi della contaminazione e della repressione, sapendo che, per quanto gli si spari addosso, “nessuno può spegnere il sole”. (matilde collavini)